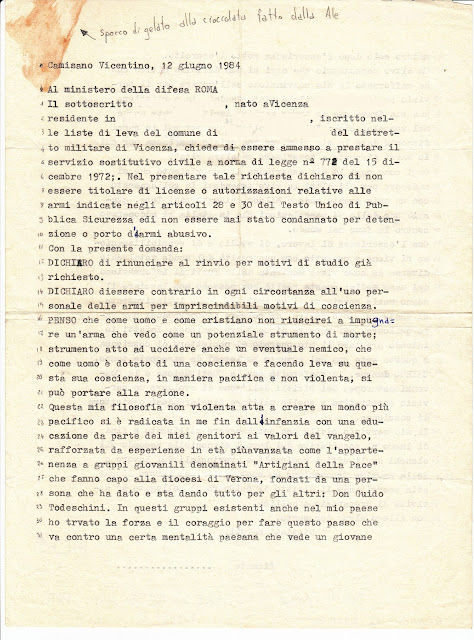Tempo libero n.1 IMPROBABILI RITORNI.
L'entusiasmo di Loris per l’autostop influenzò
molto il nostro gruppo.
Anche il fatto di non avere soldi fu di
aiuto. Così, con uno zaino e un pollice, si partiva. Una tappa obbligata era
Taizé, dalle parti di Cluny, in Borgogna.
Taizé la visitammo tre volte e altrettante
ne fummo espulsi. La quarta volta evitammo di tornare. 700 chilometri affidandoci al caso, e non
era neanche il viaggio più lungo. Ci caricavano i camionisti e poi ci procuravano
passaggi con le loro ricetrasmittenti CB. Nelle aree di sosta dell’autostrada
passavamo di camion in camion.
I camionisti tra loro parlavano in codice:
«sono sulla grande carreggiata con due
gringhelli, devono prendere la carraia per …». Eravamo gringhelli e
gringhelle.
Si dormiva fuori, sotto un cavalcavia o
sul retro di una stazione di servizio. Poi arrivavi. A volte impiegavi un
giorno, altre volte due o tre, ma arrivavi. Potevano succedere imprevisti lungo
il viaggio, e alcuni furono proprio rocamboleschi.
Nei recinti dei pascoli, ad esempio, c’erano
vacche e tori. Il toro controlla il suo harem e garantisce sicurezza e difesa
del proprio territorio. Una sera, era già buio, Loris ebbe necessità di
appartarsi, vide un recinto e ci saltò dentro. Fu così che scoprì che anche gli
stalloni difendono il territorio. Infatti, nel nero pece della notte senza
stelle, si sentì un potente nitrito ed un pesante scalpiccio di zoccoli sul terreno.
Fu così che Loris si esibì nel migliore salto ad ostacoli al buio che nessuno
prima di allora avesse mai sperimentato.
A Taizé ti accoglievano in una tenda con
pagliericci, o anche niente, e dormivi lì per terra. Un anno Loris mostrò la
sua vistosa cicatrice alla spalla, mentre io zoppicavo, da consumato attore.
Due giovani suore si impietosirono e ci diedero il loro letto. Dormirono per
terra, nella tenda comune, al nostro posto, le brave suore.
Incontravi tutte le lingue del mondo, e
persone incredibili.
Un vecchio tossico che ti mostrava le
autostrade di vene tutte rovinate dai buchi. Cercava di convincerti, o
convincersi, che stava cambiando, anche se dopo un po’ ti chiedeva soldi, o
almeno un limone. Oppure la bellissima spagnola mora che camminava scalza col
suo vestito da flamenco giallo e arancione, leggermente pazza, ma andava bene
uguale.
Ti dovevi impegnare iscrivendoti ad un
gruppo: c’erano il cooking group, il cleaning group, il prayer group e molti altri. Noi creammo lo swimming group: andavamo a nuotare in un fosso lì vicino. Una sera ci incaricarono del silence group, ci diedero vari cartelli
in varie lingue, dovevamo girare per la comunità ed invitare tutti a fare
silenzio e a dormire. Trovato un prato, piantammo a cerchio
tutti i cartelli e con i sacchi a pelo dormimmo beatamente avvolti dal rispettoso
silenzio della comunità.
La chiesa di Taizé è maestosa, piena di
lumini che calano dal soffitto, senza panche né sedie. In centro un grande
Cristo crocefisso, sdraiato a terra. Molti si stendevano al suo fianco per
pregare. Ivano dormì abbracciato al Cristo crocefisso, la scena era tenera e
dolce, poteva sembrare un legame d’amore profondo. Purtroppo, il russare deciso
nella grande chiesa silenziosa non poteva passare inosservato.
A Taizé c’erano le docce calde a pagamento,
o le docce fredde, molto fredde, terribilmente fredde, ma queste erano gratis.
Quando ci lavavamo i nostri ululati scuotevano il villaggio, ma era solo un
modo per cercare di superare il trauma. Bigi una volta rimase incastrato in una
doccia, sbraitando per il freddo fu costretto ad arrampicarsi sulla porta per
uscire. Prima di lui, terrorizzati, uscirono tutti quelli che erano nei bagni.
Vivere senza spendere soldi era un’impresa
complicata, ma la sfida ci colse preparati. C’era un negozio, una specie di bar
con un piccolo supermercato dove comperavi quello che serviva, dal sapone alla
birra: l’Ogiac.
Quando entravi ti consegnavano un
biglietto dove veniva scritto quello che comperavi, all’uscita consegnavi il biglietto
e pagavi. Era troppo facile: entravi in due, uno segnava nel suo biglietto tutto
quello che prendeva, nel secondo biglietto segnavi gomme da masticare.
All’uscita pagavi le gomme e nascondevi il resto.
L’anno dopo consegnavano un biglietto che alla
fine si doveva restituire anche senza acquisti. Una persona un biglietto, ma
non era impossibile, richiedeva solo più fantasia. Si entrava e ti davano un
biglietto. A fianco, fuori dall’Ogiac, c’era una
finestra dove potevi comperare hot dog con la mustard, una senape, abbastanza
forte. Perché i francesi chiamino mostarda la senape non si sa, ma funziona
così. La procedura era semplice: entravi,
prendevi il biglietto e andavi in giro cercando gli hot dog, poi ti avvicinavi
alla cassa, sfoderavi il miglior sorriso ed il peggior inglese, operazione
piuttosto semplice visto la nostra conoscenza delle lingue, chiedendo alla
simpatica cassiera dove comperare l’hot dog. Lei, cercando di aiutare lo
sfortunato avventore ti spiegava che gli hot dog erano all’esterno. Con molti
saluti e riverenze uscivi nascondendo il biglietto bianco. Quando tornavi,
magari il giorno dopo, prendevi un nuovo biglietto comperavi di tutto ed in
cassa lasciavi il biglietto bianco del giorno prima.
L’Ogiac poi decise di farsi pagare in
contanti e subito quello che si comperava.
A Taizé non si trovava vino, ed era un
problema perché con il vino si potevano organizzare brindisi e chiacchierate,
anche, e soprattutto, con ragazze di altre nazioni.
È risaputo che il vino aiuta a comprendere
meglio le lingue straniere, ma l’Ogiac vendeva solo birra. Ivano risolse il problema: «Scusate, ma se
i preti dicono messa, spezzano il pane e bevono vino, in chiesa il vino deve
esserci». Effettivamente il ragionamento calzava, ma
chi ha il coraggio di andare a prendere il vino benedetto dentro una chiesa?
Tutti. Tutti noi a turno andavamo in chiesa.
Dietro l’altare maggiore una porticina portava in una stanzetta dove si teneva
il vino per le messe. In effetti pensavamo di essere originali e
un po’ malefici nel risolvere così la questione etilica. Brindammo con piacere
e svuotammo in fretta la prima bottiglia di vino bianco, ma quando gettammo il
vetro oltre la siepe, con molto stupore sentimmo il tintinnio di altri vetri.
Qualcuno prima di noi aveva avuto lo stesso problema e trovato la stessa
soluzione.
Bisognava anche procurare il cibo a costo
zero.
Funzionava una specie di mensa dove
prendevi una ciotola ed un cucchiaio, che poi dovevi risciacquare con sabbia e
acqua e impilare. Ti davano il cibo solo se presentavi un
bollino colorato, ogni settimana diverso dalla precedente. I bollini, grandi
come francobolli, si compravano all’accoglienza. Questi bollini erano stampati in un foglio,
da dove venivano strappati, e il contorno gettato, e quei preziosi ritagli
erano la nostra salvezza. Prima cosa: impossessarsi dei pezzi
scartati e mettersi in fila dove ci fosse una ragazza che serviva,
possibilmente giovane; poi avvicinarsi, farsi servire, sorridere e fare un
complimento carino con lo scopo di distrarla, quindi buttare il rettangolino di
carta nel mucchio con i bollini veri. Era importante non farsi servire dalle
suore e dai maschi.
È difficile fare complimenti alle suore e
distrarle: sono vecchie di mestiere ed il fascino latino non suscita il loro
interesse. Con i maschi è più complicato, puoi fare dei complimenti che
potrebbero non essere graditi, il che è male, ma peggio, potrebbero essere
graditi e quindi non privi di conseguenze.
A fianco della fila per il cibo c’era un
tabellone, dove venivano appese le cose che si trovavano smarrite in giro per
il campo. Un giorno, passando, Loris vide una
striscia di bollini infilzata con una spilla; io creai un diversivo, facendo
cadere la ciotola e creando confusione per attirare su di me l’attenzione della
gente in fila. Bigi staccò i bollini.
Ma era una trappola.
Un malefico piano ideato per smascherare
le nostre faticose piccole truffe.
Ci lasciarono mangiare poi vennero a dirci
che i nostri bagagli erano all'accettazione ed il pullman per Cluny sarebbe
arrivato da lì a poco. Fu un’ingiustizia: «è troppo facile fare i pastori per le
pecore buone» «noi siamo le pecore nere, siamo più
bisognosi del vostro aiuto» «vorremmo parlare, spiegarci, farvi capire
che siamo pentiti».
Provammo in tutti i modi di convincere quei
buttafuori del nostro vero pentimento, ma non funzionò.Anzi, si arrabbiarono
parecchio quando Bigi disse «e poi il vino della vostra chiesa fa schifo!» Fummo
espulsi.
Quella fu la terza volta in tre anni.
La prima volta fu di mattina. L’Ogiac era
aperto, stranamente, visto che c’erano i vari gruppi di lavoro all’opera. Stavamo
seduti al sole a berci una birretta, quando in quattro arrivarono chiedendoci
se conoscevano lo swimming group. Con
entusiasmo dicemmo: «siamo noi!» Ci fecero salire in corriera per Cluny, gli
zaini erano già a bordo.
Il trucchetto dei cartelli per creare la
zona silenziosa funzionò fino alle undici del giorno dopo. Giusto in tempo per
salire la seconda volta sul pullman per Cluny.
L’ultimo pullman per Cluny fu memorabile.
Loris, da nostalgico, pensò di lasciare un piccolo souvenir. Era da un paio di
giorni che passava il tempo ad insegnare una canzoncina a due ragazze tedesche
che non parlavano italiano, e quindi, probabilmente, non conoscevano neanche il
dialetto veneto. Ma la famosa canzoncina di Fra Martino sì.
Solo le parole erano un po’ diverse, anche se la rima, in fondo, c’era. Il
frate era Fra Pierino, l’addetto al gruppo italiano, e le campane non facevano din – don – dan, ma la rima c’era e
ricordava molto il famoso ip ip ip inventato a casa di Capo.
Mentre stavamo salendo per la terza ed
ultima volta nel pullman, Loris vide le ragazze tedesche e le salutò: lui
cantando il vero Fra Martino, loro in coro ad alta voce invece a rispondere con
la versione alternativa e blasfema.
Non è vero che gli uomini di chiesa sono
sempre pacati e tranquilli: quella volta erano indecisi se salire a bordo e
strozzare il direttore del coro o stare a terra cercando di zittire le procaci
fanciulle che si esibivano dimostrando una gradevole capacità di sacramentare a
cappella nel nostro dialetto. La situazione colse alla sprovvista i bravi
custodi quel tanto che bastò a far partire il pullman. A bordo, giurammo di non
rimettere più piede a Taizé per paura di essere riconosciuti e con il fondato dubbio
di essere schedati a vita, con tanto di foto.
Raffaele aveva dato la maturità e voleva
fare un giro in autostop. Io volevo fare il servizio civile e
quell'estate desideravo andare a Massafra, dove si svolgeva un campo scuola sulla
nonviolenza, di una settimana. Andammo insieme, direzione Pianoro della Masseria a Massafra,
Taranto: 950 chilometri. L’Italia è lunga e stretta, soprattutto lunga. Ci vollero due giorni. La prima notte
dormimmo dietro una stazione di servizio, trovai un segnale stradale rotondo del
diametro di un metro, lo posai tra i due argini di un fosso asciutto e ci
dormii sopra, Raffaele invece dormì nel campo. La sera dopo arrivammo a
Massafra. Era quasi notte, verso le ventitré. Un branco di cani randagi ci
accolse e al nostro passaggio continuava ad abbaiare.
Quando cominciarono ad accendersi le luci
di qualche finestra ci allontanammo dal paese e decidemmo di cercare il pianoro
il giorno dopo. C’era un grande albero in mezzo a un campo
arato da poco. A calci spaccammo alcune zolle per creare una zona piana per
dormire. Poi stendemmo le stuoie e i sacchi a pelo. Mangiammo sgombro in scatola e pane in
cassetta, con l’acqua. È importante avere l’acqua, perché lo sgombro ti secca
la bocca, e crea un pastone che digerisci dopo vari giorni. Senza acqua rischi
di morire strozzato dallo sgombro, e non è una bella cosa morire per colpa
dello sgombro assassino.
La mattina successiva scoprimmo che
l’albero segnava il confine di due proprietà: una arata, dove avevamo dormito
rompendoci la schiena, l’altra un prato di soffice erba. La notte prima, troppo stanchi, avevamo
scelto il lato sbagliato .Arrotolate stuoie e sacchi, indossati gli zaini, partimmo
per il paese .Il caffè in vetro esiste solo nel Sud Italia, come la granita al
caffè. Impossibile riuscire a bere una cosa più buona nelle mattine d’estate. Con un ultimo passaggio in trattore su una
strada sterrata arrivammo al Pianoro della Masseria, dove vedemmo i trulli per
la prima volta. Raffaele ci dormì, dentro a un trullo, io invece mi sistemai sulla
terrazza della casetta nell’orto. Volevo dormire lì perché di sera avevo il
cielo e infinite stelle da guardare. Alla mattina, scendendo per la colazione,
passavo per l’orto e mangiavo una manciata di pomodorini piccoli, tondi e
dolcissimi.
Tutti i corsisti si raccolsero, venimmo
disposti in fila con la fronte verso il sole. Lì conoscemmo Antonino Drago, docente
universitario esperto di nonviolenza, capelli chiari, barba, baffi e occhiali.
Pareva un professore saggio e a modo, solo stonava un po' la sua tunica corta
con disegnato sulla schiena un grande sole. Ci parlò di tecniche nonviolente,
di rispetto della natura e del bisogno di fermarsi per ascoltare i rumori della
vita. Ci insegnò l’importanza di prendere coscienza dello scorrere del tempo.
Ogni mattina, prima della colazione, ci
mettevamo in fila, fronte al sole, per rilassarci e ascoltare il proprio
respiro. Poi bisognava rompere le righe, abbracciare e baciare tutti gli altri.
La colazione consisteva in caffè d’orzo, pane, marmellate fatte in casa,
frutta.
«Ma che cos'è questa tisana che non l’ho mai
bevuta?» Raffaele non conosceva il caffè d’orzo, ma io sì.
Ricordo una pentola dal fondo bruciato e
nero. Mia madre ci metteva l’acqua e due cucchiai di orzo, poi lasciava
bollire. Una volta freddo filtrava tutto e metteva il liquido in una bottiglia,
in frigo. Veniva usato nel caffellatte al posto del caffè bon, quello riservato agli ospiti. A
Massafra però l’orzo non lo filtravano.
All’inizio ci stavamo attenti, ma poi
mangiavamo tutto. Anche lì in dotazione davano una ciotola di legno ed un
mestolo, che pulivamo con sabbia e acqua, alla faccia del solepiatti. Ognuno aveva
dei compiti a rotazione: pulire la cucina, preparare il pranzo, raccogliere le
verdure e raccogliere lo sterco secco delle vacche per portarlo nella
concimaia. Molti preferivano pulire le verdure. Roba da rimpiangere lo swimming group. Ad ogni ora suonava una campanella: tutti
si fermavano, fronte al sole. Liberavi la mente ed ascoltavi i rumori. «Il
lavoro distrae, non ci si accorge di essere vivi e il tempo passa nella nostra
indifferenza, perdiamo vita senza accorgersene». Uno dei tanti insegnamenti di
Tonino Drago. Al pomeriggio facevamo yoga. Si imparavano
posture incredibili; come quella nella quale stavi in equilibrio su una gamba
sola, l’altra gamba piegata ad angolo di lato, con la pianta del piede a
toccare il ginocchio della gamba a terra. Le mani distese sopra la testa con i
palmi uniti a creare una specie di punta sopra la testa. Erano comuni i
capitomboli.
Una sera ci portarono a Massafra per una
conferenza, senza cenare, perché era previsto un rinfresco. Dato che gli
argomenti erano noti, il gruppo del pianoro della masseria decise di girare per
il paese, perdendosi. Mi trovai in mezzo a delle viuzze, poi vidi un
vecchietto. Gli chiesi se per caso aveva visto dei ragazzi in giro. «Ieni, ieni
co mie ca te portu ieu a du stanu», non avendo con me il vocabolario pugliese-veneto
lo seguii per curiosità. Il vecchietto entrò in una casa, bianca.
A dire il vero tutte le case erano bianche
e fatte in modo strano, un misto di costruzione tra una grotta e una casa.
Spesso i tetti non c’erano, quasi tutte finivano con la terrazza, dicevano
servisse per raccogliere l’acqua, o per costruirci un altro piano se bisognava
ingrandire la casa. Una volta entrati, il vecchietto mi portò giù per una
stretta scaletta di cemento, bianca. Sotto, grande come tutta la casa, c’era
una cantina con botti di legno di ogni misura, e seduti in cerchio tutti i
ragazzi della masseria con un bicchiere in mano. Raffaele aveva le guance
rosse, e a guardarli bene, anche gli altri erano rubicondi. Di certo non erano
al primo bicchiere. Anch'io gustai il vino e, senza accorgermene, divenni
rubicondo anch’io.
Fu una rivelazione: era un vino bianco,
secco e fermo con una buona gradazione ed un gusto strano, fruttato, e il
profumo che ricordava l’uva, ma anche la frutta. Non si capiva bene. «Ede la
pesca, ogne famiglia tene nu truccu pèl u mieru, a casa noscia mitimu la pesche
cu fermentano lu mostu». Ora capivo il nonnino, non servono vocabolari nelle
cantine. Il segreto del nonnino consisteva nel mettere delle pesche nel mosto,
e queste davano un profumo inebriante. Ora dovevamo mangiare qualcosa. In
qualche modo ci alzammo in piedi, salutammo il nonnino che, gentilmente, ci
aiutava a salire i gradini, quindi uscimmo. Poi il vecchietto ci rincorse
tirando uno di noi per un braccio «Ehi, stu vagnone e buesciu? Nu lu putiti
mica lassare a quai!!». Capimmo di avere dimenticato uno in cantina e che il
nonno non voleva tenerselo, allora lo portammo con noi.
La conferenza era ormai finita e
cominciarono a comparire pizze enormi, focacce fatte con olio, pomodorini e
origano, calde e profumate. Misero in tavola anche un cesto di pomodori, una
vasca di terracotta con acqua, bottiglie di olio, sale e vasetti di acciughe.
Su un paio di cesti di vimini c’erano mucchi di ciambelle di pane secco e
durissimo.
Scoprimmo le friselle e fu una delizia, a
non contare il primo morso di Raffaele, che per poco non ci rimise un incisivo.
Per mangiare le friselle, senza perderci i denti, c’è un solo modo: prendere la
frisella e bagnarla nell’acqua, poi strusciarci sopra dei pomodori fino a
romperli, irrorarla di olio, un pizzico di sale, e allora sì che puoi
mangiarla. Chi voleva aggiungeva origano o acciughe. Scoprimmo anche un vino
rosso, il cui nome suggerisce il gusto: il Primitivo. Il suo nome dice tutto.
Altro di quella serata non ricordo.
Durante i pomeriggi stavo all'ombra di un
olivo enorme; accanto a me, chissà per quale motivo, stavano tutti i bambini e
le bambine che abitavano lì. In me vedevano qualcosa che Raffaele non capiva, e
nemmeno io capivo. A Massafra abbiamo incontrato persone incredibili. Del resto,
cosa potevi aspettarti in un campo sulla nonviolenza dove raccoglievi sterco
secco, praticavi yoga e alla mattina stavi di fronte al sole ad abbracciare e
baciare degli sconosciuti?
Tra questi sconosciuti, un frate
cappuccino in incognito, senza saio. Una sera ci raccontò della madre morta da
poco, e di una poesia a lei dedicata, che le aveva scritto per il suo funerale.
Lo invitammo a recitarla per noi.
“il testamento dell’allodola” di Flavio Gianessi
Ti lascio terra color delle mie piume
e più dentro a te
entro nel tuo corpo
con il mio color di te
ti lascio il corpo.
Prendimi mentre ti lascio
tienimi forte e leggera
per l’ultimo mio volo
quando entrerò in te
con gli occhi della sera.
E tu, a te sera
lascio il mio sguardo
gli occhi
quasi addormentati come ogni sera
perché mi fido di te cui ogni sera affidavo gli occhi
e poco prima dell’alba mi risvegliavi silenziosa
e ti vedevo mentre la luce ti prendeva in sposa
con gli occhi dell’aurora.
Luce?! Sole?!
Se gli occhi
ho donato alla sera a te cosa do?!
Tutta la mia forza il mio calore
quando scaldavi il cuore
e ti correvo incontro
e ti giravo attorno
e ti cantavo il canto che tu sai
ed eri mio
e non ti avevo mai.
Ed eri mio
quando scioglievi inverno
e a me donavi primavera
e l’acqua di te calda nella sera.
Acqua?
A te che mostrasti per prima il mio volto
laggiù nel mio stagno pieno di voci e di
rumori amici che non si tacciono a sera
a te acqua, a te e al vento
do il mio canto la mia preghiera.
Il vento giocava con te e con le nubi
come dei riccioli di fanciulla
ingenua e casta.
E portavi lontano le mie ali
e la mia voce
e il color delle mie piume;
solo ti prego pioggia di non scendere fredda
sulle mie ossa ad impastarmi di terra
ma calda dammi l’addio.
E voi
fiori
frutti
verde grano dei boschi e dei prati
e tu rosso tulipano
cosa lascio a testamento a voi
che tanto avete dato a me
e ai tanti amici
una preghiera e l’ultima
coprite voi
questa mia piccola fossa senza sponde
così come vi semina il vento
che seminò il mio canto ed ora
l’ultimo
m’accoglie.
Silenzio e commozione.
Flavio spiegò che l’allodola, quando sente
di dover morire, vola verso il sole e canta per lui fino a cadere sfinita per
poi lasciarsi andare.
C’erano anche due ragazze torinesi ed un
loro amico, uno spilungone magro e dinoccolato, con un cespuglio riccio e
biondo in testa e un paio di occhiali con montatura e lenti ambrate. Tornando
da Massafra beccammo un bel passaggio lungo, Raffaele era a fianco dell’autista
e io sonnecchiavo dietro. In quel passaggio Raffaele raccontò all’autista tutta
la sua paura per l’esame di maturità, la difficoltà di concentrarsi, la
responsabilità del risultato e il dubbio di non riuscire a regalare ai suoi la
soddisfazione di un bel voto.
Di tutto questo, in quasi duemila
chilometri, non ne parlò mai con me. Scelse un estraneo, un occasionale e
gentile autista che non avrebbe rivisto mai più. Strano, ma a volte è più
facile condividere i propri stati d’animo con uno sconosciuto, piuttosto che
con un amico.
In autunno decidemmo di andare a trovare i
tre torinesi. Ci accolsero a casa dello spilungone. Passammo una giornata
dentro a una stanza piena di cuscini e materassi, in penombra. Una lieve musica
delicata faceva da sottofondo alle nostre chiacchiere. Lo spilungone ci raccontò che aveva
montato dei nastri speciali che riproducevano quella musica per ore. Per un
giorno intero parlammo di qualsiasi cosa, con lui e con le due ragazze.
Mesi dopo, quando Torino era solo un
ricordo, arrivò una lettera dalle due ragazze. Il loro amico, lo spilungone con
gli occhiali ed il cespuglio in testa si era ucciso. Aveva svuotato un flacone
di insetticida in un bicchiere e lo aveva bevuto. Lo trovarono dentro la
stanza, tra i cuscini e la dolce musica di sottofondo che ancora girava nel
mangiacassette. Si uccise così, come un insetto. Non
lasciò una parola, un saluto o una riga. Decise di tagliare il filo sottile che
lo sosteneva appeso, in attesa di cadere. Lo tagliò immerso nella sua musica
preferita, uccidendosi in una agonia terribile.
Ognuno aveva il proprio stile nel
rimediare i passaggi. Certo, agitare il pollice è cosa nota,
anche scrivere la destinazione su di un pezzo di cartone può funzionare. Qualcuno
preferiva chiedere l’autostop esattamente sotto i cartelli dell’autostrada con
scritto divieto di autostop, che era
ironico e faceva tendenza. Ivano usava una tecnica tutta sua, un cartone con
disegnato un punto di domanda, ma lui era oltre.
Bigi e Ivano andarono a Viareggio, 350 chilometri,
un viaggetto.
Era un campo di lavoro di Mani Tese, con
una serie di incontri sulla nonviolenza. In quell’occasione conobbero il grande e
grosso Marco Pannella, con tanto di prova fotografica. Pannella era una
persona, oltre che una personalità, imponente. Nella foto si vede Marco
Pannella al centro, alto due metri e massiccio. Ivano, alto un metro e settantacinque,
arrivava alla sua ascella. Bigi alto uno e novantasei, era leggermente più
basso di Marco, ma decisamente più esile. Nel gruppetto della foto c’è anche un
ragazzo col caschetto, biondino e piccolino, uno sconosciuto. Il volto furbetto
e curioso, un vero spaccamaroni che continuava ad infilarsi in tutto quello che
Ivano e Bigi decidevano di fare, e si ostinava a stare con loro, simpatico come
un gatto nelle mutande.
Così i nostri amici pianificarono una
strategia alcolica per liberarsi di lui. Alla sera lo invitarono ad uscire con
loro e gli offrirono uno spritz. Lo spritz, comune aperitivo in Veneto,
risultava totalmente sconosciuto a Viareggio. Quando Ivano chiese al barbuto e
rubicondo barista: «tre spritz, uno liscio, uno macchiato Aperol e due
macchiati Campari»
il barista lo guardò come un merluzzo
guarda Capitan Findus.
Scoperta la completa ignoranza del
barista, optarono per una rapida lezione, con dovizia di particolari e di
assaggi. Così si partì dalla base. «Lo spritz nasce come acqua gasata e vino
bianco, qualcuno chiede lo spritz rosso, basta usare vino rosso. Poi c’è lo
spritz macchiato. Quindi una parte di acqua, due di vino, rigorosamente bianco,
e una di Aperol o Campari. Alcuni coraggiosi usano degli amari, tipo Cynar. Poi
c’è il bianco macchiato, solo vino e i vari liquori». Ivano spiegava tutto
questo dal bancone del bar. Il barista si era messo dal lato dei clienti e per
ogni tipo di miscela proposta si provvedeva all’assaggio.
Fu solo l’inizio. Terminata la lezione si aprì un
contenzioso riguardo al conto, che ammontava a circa ventimila lire. Tentarono
di convincere il barista che aveva ricevuto una lezione da un importante esperto
di prodotti locali veneti. Alla fine si accordarono per diecimila lire così
ripartiti: zero lire al maestro Ivano, zero lire al suo assistente Bigi,
cinquemila lire al ragazzo col caschetto e cinquemila lire al barista perché
anche lui era dalla parte dei clienti. Tutti convennero che fosse una giusta
mediazione, anche il barista, che aveva ancora gli occhi da merluzzo, solo un
pochino più offuscati.
La via dell’alcol era appena iniziata. Più
avanti trovarono una fiaschetteria e comperarono la vernaccia. Bigi e Ivano
litigarono ferocemente tra loro per offrire la bottiglia che alla fine fu pagata
dal caschetto per evitare spargimenti di sangue. L’idea era di portarla al
campo di lavoro, ma dopo poco venne stappata dal provvidente cavatappi di Bigi
e procedettero al furbesco assaggio. Mentre il caschetto tracannava, i nostri
due, gatto e volpe, facevano solo finta di bere. La povera vittima aveva
cominciato a ridere a vanvera e parlare a caso. Continuarono a camminare per le
strade del centro, mentre il tempo passava. Alla fine si ritrovarono dentro un
bar, per controllare se lì conoscevano la grappa. Era ormai tardi e in quella
bettola trovarono due trans che chiacchieravano simpaticamente col barista.
Quando videro i tre intuirono che due di loro stavano massacrando il terzo. Un
poco alla volta si aggregarono al tavolo e si cominciò una discussione amichevole
al sapore di grappa. Fu servito il primo giro, che il caschetto tracannò prima
degli altri. Questa era un’ingiustizia, perché bisognava fare il brindisi.
Prontamente gli servirono un altro grappino. Si brindò e appena l’incauto posò
il bicchierino, praticamente vuoto, per errore Bigi lo urtò, rovesciando sul
tavolo poche gocce di grappa. Rammaricato offrì un altro grappino che il
caschetto, ormai perduto nella nebbia, goffamente tentò di rifiutare.
Le grappe vennero offerte dai due trans, Samantha
e Deborah di notte, Aldo e Dino, muratore e macellaio, di giorno. Alla fine, parecchio
più tardi, riportarono il caschetto al campo. Lungo la strada, un paio di volte
lo raccattarono da terra dove si ostinava a sdraiarsi per dormire. Entrati, lo
legarono con la cinghia delle sue braghe alla ringhiera delle scale e lo
salutarono invitandolo a cantare per loro una ninna nanna. Appena questi
dimostrò di possedere un’ugola degna di Claudio Villa, i due si dileguarono. Si
accesero le luci di tutte le camere, tranne che di due. Il giorno dopo Ivano e
Bigi vennero richiamati dal responsabile del campo, il quale espresse il suo
disgusto per quello che era successo.
Anche i nostri furono del medesimo parere,
e raccontarono come il Claudio Villa di Viareggio si fosse ingollato quattro o
cinque spritz. «Spritz??», disse il responsabile del campo, così Ivano spiegò
nuovamente tutta la teoria al riguardo. Poi raccontarono di come si fosse
offerto di comperare una bottiglia intera di vernaccia costringendoli a bere.
Di come avevano passato la notte in una bettola con trans e grappa. Erano
stupefatti e delusi che non si fossero fatti opportuni controlli sulle persone
che partecipavano al campo, e che chiunque potesse iscriversi.
Tre giorni dopo, il caschetto si riprese e
venne invitato con forza ad andarsene, ma non prima di essersi scusato con
Ivano e Bigi. Fu molto credibile e visibilmente dispiaciuto. Disse che il
responsabile del campo gli aveva raccontato cosa aveva fatto, e che non capiva
come fosse successo, perché lui non era così. Purtroppo non ricordava niente
della serata, e si scusava per aver svegliato tutti, e pensare che credeva di
essere stonato. In particolare si scusava molto con Ivano e Bigi. Li
considerava due affidabili amici e li ringraziò molto per averlo aiutato a
rientrare. Ma non si spiego ancora come avesse fatto a legarsi da solo alla
ringhiera, questo proprio non lo capì mai.
E non lo capì nessuno.
Ci fu un unico viaggio di sesso misto e
coppie incrociate: quello di Schizzo e mio. Occhi azzurri, capelli lisci e
lunghi, persona nota per la sua calma: per questo la chiamavamo Schizzo. Schizzo
stava con Gnagno, io stavo con Celeste. Gnagno e Celeste erano stati invitati a
venire via ma né l’uno né l’altra potevano. Così la coppia trasversale, Schizzo
ed io, partimmo da buoni amici quali eravamo.
Barcellona, 1200 chilometri, non male come
prima tappa. Il giro prevedeva Spagna e Portogallo, le tapas, la paella e la
sangria in Spagna, il Porto in Portogallo.
Nulla di tutto ciò avvenne.
Era un viaggio atteso da tempo. Racimolavo
soldi lavorando in vari modi, una parte serviva per il viaggio, un’altra per
mantenere la famiglia, cioè Ivano e Bigi. La domenica mattina commesso a
vendere scarpe, alla sera cameriere, il sabato sera cameriere, ma da un’altra
parte. Il sabato mattino l’imbianchino, durante l’estate il barista,
occasionalmente il commesso in un negozio di vestiti. A settembre la vendemmia,
poi altri lavoretti, come la raccolta di polli alla notte.
Ero pronto, ed anche la mia sfiga lo era.
Partimmo fiduciosi ed entusiasti con la
speranza di verificare se è vero che l’autostop con una ragazza rende tutto più
facile; e così fu, per Schizzo. Ci caricò un ricco signore in vestito blu e
maggiolone tre porte nero, sedili in pelle bianca. Caricò Schizzo sul sedile al
suo fianco, e gettò me e gli zaini dietro. Saliti a bordo srotolò la capote del
maggiolone, alzò i vetri dei finestrini anteriori e partì con il suo Herbie.
Davanti brillava il sole ed un leggero venticello rinfrescava i volti, amabilmente
si chiacchierava del più e del meno. Dietro un uragano di correnti d’aria,
l’ululare del vento e del motore non permetteva di capire niente.
Poi ci caricò una famiglia inglese: moglie,
marito e due figli. Il marito fece scendere la moglie, che andò a dormire in
roulotte, grata di avere trovato un baby sitter, cioè me. L’inglese fece sedere
Schizzo al suo fianco. Io, gli zaini e i due figli dietro. Subito i bambini si
sedettero sopra di me e cominciarono a litigare, aprendo e frugando negli
zaini. In prossimità della frontiera ci chiesero di salire dentro la roulotte e
di nasconderci perché non potevano trasportare sei persone. Attraversammo così
la frontiera Italia / Francia nascosti, come clandestini.
Era l’imbrunire quando arrivò l’ultimo passaggio
della giornata. Ci caricò una macchina guidata da tre ragazzi. Schizzo salì
davanti come da consuetudine. Era un po’ stanca. Io dietro con due tipi. Lungo
il percorso iniziarono una drammatica conversazione in inglese. Ascoltavo in
silenzio, con il mio inglese minimalista. Schizzo, forse per non sembrare
scortese, sorrideva fingendo di capire con cenni di consenso. Ad un certo punto
cominciarono a suonarmi in testa campanelli di allarme. Nel discorso dei tre
ogni tanto comparivano parole e frasi che si riferivano ad azioni legate alla
fase riproduttiva dei mammiferi. Schizzo, sempre più stanca, era in loop e
continuava a dare cenni di assenso. «Secondo me dovresti cominciare a dire no,
oppure puoi dire anche sì, se hai capito cosa chiedono, ma per cortesia fammi
scendere».

Schizzo si scosse dal torpore e dopo pochi
chilometri chiese di scendere con urgenza. Ci fecero scendere nel nulla, nei pressi
di Aix-en-Provence, lungo la statale. Notte, buio pesto, tirava vento, ci
trovavamo a 700 chilometri da casa e 500 da Barcellona, in mezzo al niente. Per
fortuna lì vicino c’era un canneto, sembrava il posto giusto dove cercare un
rifugio per la notte, sfruttando le canne per ripararci dal vento. Entrammo in
quel boschetto e uno strano ronzio continuo ci accolse, ma non ci badammo.
Avevamo fame e sonno. Stesi stuoie e sacchi a pelo, Schizzo si gustò un succo
di frutta, io aggredii il panino di sgombro e pane in cassetta, doppio strato.
L’accordo era che Schizzo portava da bere, io il cibo. Per un malinteso entrambi
avevamo portato il cibo. Così mentre Schizzo, che aveva bevuto l’ultima cosa
liquida, si stese e dormì, io girovagai inutilmente alla ricerca di qualcosa
per poter inghiottire lo sgombro che mi incollava la bocca. Alla fine la
stanchezza ebbe il sopravvento e crollai dentro al sacco a pelo, cullato da
quello strano, insistente ronzio.
Dopo mezz'ora eravamo in piedi a prenderci
a schiaffi, tentando di uccidere il maggior numero di zanzare possibili. La
guerra era impari, i piccoli vampiri alati ci aggredivano da tutti i fianchi.
Provammo ad infilarci nei sacchi a pelo a mummia e chiudere tutti gli accessi,
lasciando libero solo lo spazio necessario per poter respirare. Alla mattina ci
ritrovammo con naso e bocca gonfi di punture. Così, precursori del botulino,
inferociti per la notte insonne e disidratati, cercammo subito un altro
passaggio. Sarebbe stato l’ultimo dell’andata e il primo del ritorno.
Oltretutto, puzzavo di baccalà.
Occupati dalla caccia alle zanzare e
stravolti dalla stanchezza, non avevamo notato il curioso profumo di baccalà
che il mio nuovo sacco a pelo emanava. Lo avevo comperato da poco nel più
grande e rifornito supermercato del paese. Più che un supermercato era un
emporio dove si vendeva di tutto, dal fieno al migliore grana padano della zona.
La specialità però era il baccalà, che il proprietario comperava direttamente
dai produttori norvegesi in balle rotonde. Era la sua grande passione. Prima di
venderlo lo passava sotto una specie di strana macchina a pedali che azionavano
un martelletto. Lo batteva tutto per sfibrarlo e rendere il baccalà secco più
morbido, una volta bagnato. I sacchi a pelo erano sulla mensola esattamente
sopra il baccalà, e siccome l’odore era ovunque, dentro al negozio non si
notava. Comperai il nuovo sacco a pelo e lo avvolsi con del nylon perché non si
bagnasse nel viaggio, ma al primo utilizzo il baccalà esplose nella sua
fragranza.
Si fermò una coppia di fidanzati francesi
che stavano andando a Barcellona. Nostri coetanei, il viaggio nella loro Renault
5 tre porte fu divertente e simpatico, tranne che per quel persistente odore di
baccalà che olezzava nel piccolo abitacolo. Per la prima volta, alla frontiera
Francia / Spagna chiesero le carte d’identità. La giovane coppia francese,
spiegandosi in una zuppa mista di idiomi; francese, inglese, spagnolo ed
italiano, chiese se eravamo intenzionati a visitare il famoso museo di Dalì che
si trovava lungo la strada, a Figueres. L’idea ci piaceva, così oltre alla
carta d’identità prelevammo 100 mila lire a testa, dal ripostiglio segreto
degli zaini. Furono gli unici soldi su cui contare e l’ultima volta che vedemmo
i nostri zaini.
Arrivati al bel museo, i francesi
parcheggiarono vicino alla stazione della polizia, nessuno si preoccupò di nascondere
gli zaini: c’era la polizia. Il museo era incantevole. Dalì un pazzo
visionario. Ci colpì la stanza dedicata a Mae West, dove l’arredamento visto da
un soppalco assume le sembianze del volto dell’attrice, poi la Cadillac del
taxi piovoso nello stranissimo giardino. Uscimmo felici, fino alla macchina. Il
portellone del bagagliaio era rotto, gli zaini spariti, con tutti i soldi.
Anche i francesi erano rimasti con poca roba. Se avessimo avuto un gatto
avremmo potuto trovare gli zaini seguendo l’odore del baccalà.
Andammo a fare la denuncia alla vicina, ed inutile,
stazione di polizia. Nella denuncia parlavano di un chico, di una chica e di
un coche, più che una denuncia
sembrava una barzelletta. Decidemmo di andare comunque a Barcellona, al
consolato italiano, dove chiedere e ricevere dei soldi; illusi.
Una volta in auto, mandammo in Figueres i
ladri e Dalì, e da lì in poi continuammo con i pochi soldi rimasti.
Senza altre fermate, Barcellona ci
accolse, arrabbiati e tristi. Trovammo alloggio tutti e quattro in una pensione
economica, molto economica. Nel prezzo c’era il bagno in camera, letteralmente.
Infatti nella stanza oltre ai due letti c’era un lavandino ed un water. La
doccia era in comune, in corridoio. Molto strani gli spagnoli. Posati gli zaini
salutammo i francesi e subito cercammo il consolato.
Non andate al consolato di Barcellona se vi
rubano soldi, è un viaggio inutile e vi sgridano, per giunta dandovi degli
stupidi per esservi fatti rubare le cose. L’unica soddisfazione che si può
ricevere è quella di scoprire che non siete gli unici allocchi italiani
derubati. La sala d’attesa era colma di italiani e il simpatico funzionario
risolse la questione dando a tutti, con democratica equità, degli stupidi per
essersi fatti derubare così facilmente ed accusandoci di far denigrare la
nostra patria da quattro furfantelli. Consigliò di farci spedire un vaglia con
i soldi al consolato e di lasciare un recapito, poi lui stesso ci avrebbe
contattati. Nessuno si fidò di lui e tutti sospettarono che il suo aiuto fosse
interessato.
Così, senza soldi, decidemmo di fare la
spesa.
Al primo supermercato ci rifornimmo di shampoo,
sapone, spazzolini da denti, dentifricio e spugne, dimostrando a nostra volta
che in caso di necessità anche i più onesti possono rubare. Tornando a casa,
incontrammo un italiano che portava al collo il pendaglio di Taizé. I pendagli
di Taizé sono costituiti da un medaglione rotondo che riporta stampata l’effige
di una colomba, creando così, da un unico pezzo, due pendenti: l’interno del
medaglione a forma di colomba e l’esterno, il medaglione con il buco. Il ferro può
essere smaltato con vari colori. Il tizio che incontrammo portava l’effige
della colomba smaltata in nero, io indossavo il medaglione con il buco della
colomba, anch'esso nero. Fu la scusa per conoscerci. Si trattò di un incontro
fugace, appena il tempo per raccontare le nostre disgrazie e salutarci.
Alla sera per tirarci su mangiammo in una
bettola: gazpacho, paella, insalata e sangria. Schizzo crollò, pianse per tutta
la sera sopra la sua insalata e non riusciva a mangiare. Io mangiai il
gazpacho, riproponendomi di non mangiarne più, poi mangiai la paella e
tracannai la sangria. Rassicurai Schizzo che tutto sarebbe andato per il
meglio, poi le chiesi se potevo mangiare la sua insalata, e lei acconsentì. Era
un po’ salata ma andava bene. Alla fine comperammo le Ducados da una matrona che passava fumando tra i tavolini e tenendo
le sigarette in un cesto di vimini. Sfiniti ci buttammo a letto per dormire.
Nella notte mi scivolò una mano a terra e sentii acqua. Accesi la luce: la
stanza era allagata. Schizzo dormiva nel suo letto.
Senza fare rumore, scesi in quella che con
molta fantasia ci avevano presentato come recepcion.
Svegliai il guardiano dicendogli «agua agua», lui si alzò, in mutande e
canottiera, aprì un frigo e mi diede una bottiglia d’acqua. Visto che il mio
spagnolo aveva grossi limiti e considerato che l’inglese e l’italiano erano
ignoti al portiere, lo trascinai su per le scale, in mutande, con suo grande
stupore.
Quando vide la camera allagata capì il
problema, il torpore notturno si dissolse, ed anche il velato dubbio che
volessi abusare di lui, e cominciò a parlarmi concitato. Vide che non capivo
niente, quindi scese e tornò e con scopettoni, secchi e stracci. Con una chiave
inglese chiuse l’acqua che usciva da sotto il lavandino, quindi cominciammo a
raccogliere l’acqua e a pulire. Schizzo dormiva beata. Verso mattina avevamo
sistemato tutto. Il tipo mi salutò ringraziandomi e finalmente mi buttai a
letto.
Due ore dopo Schizzo, pimpante, mi
rovesciò giù dal letto: «non possiamo stare qui a dormire, su dai, oggi
visitiamo Barcellona e poi vorrei vedere il museo di Picasso». Stravolto,
decisi di non ostacolarla e a rassegnarmi alla sua rinata vitalità, la seguii
per le vie di Barcellona, finsi di ascoltarla mentre mi parlava della Sagrada
Familia di Gaudì ancora incompiuta; le dissi che anche al Duomo di Milano
continuano a metterci le mani, ma mi ignorò.
Alla fine arrivammo al museo di Picasso. Non
ricordo molto delle opere del museo, ma ne valse la pena. In una stanza, ad
ammirare un quadro, con un bambino per mano ed un’amica al fianco, incontrai e
seguii discretamente Sade Adu: una visione. Amavo la sua voce, le sue canzoni, in particolare Smooth Operator e Your Love Is King.
Rimasi al suo fianco, senza intromettermi,
senza disturbarla, solo per guardarla, capire quanto potesse essere diversa da
quel che si vedeva di lei nei video. Era autentica, come speravo fosse, con la
sua lunga treccia a raccogliere i capelli e a far risaltare il suo viso dai
lineamenti lievemente asiatici. Alla fine anche il museo di Picasso mi donò
qualcosa.
Al ritorno trovammo un biglietto che il
portiere, ormai affezionato amico, stavolta vestito e sorridente, ci consegnò.
Scritto dai nostri due amici francesi, nella consueta zuppa di lingue, il
biglietto faceva intendere che avevano subito altri due scassi alla macchina.
Considerando che la Renault 5 aveva tre porte, rimaneva solo il cofano del
motore da scassinare. Valutata l’impossibilità di chiudere il coche, decidevano di tornare a casa finché
avevano ancora la macchina. Se volevamo, il giorno dopo ci aspettavano sotto
la Sagrada Familia.
Così tornammo a casa. Il
portiere, considerate le mie fatiche notturne, ci scontò una notte e ci salutò,
invitandoci a tornare. Ottenne anche la promessa che avremmo parlato a tutti
del suo albergo, e in effetti così fu.
Con gli ultimi soldi comperammo una
borsetta in cuoio da usare come bagaglio a mano per metterci i nostri averi:
gli spazzolini, lo shampoo, il dentifricio e la denuncia. La borsetta sarebbe
stata anche un piccolo souvenir da regalare a Celeste, al ritorno.
Tornammo a casa con due passaggi, senza
soste ed in un solo giorno. Un record.
I francesi ci scaricarono in un autogrill,
vicino al canneto delle zanzare per capirci. Leggendo le targhe ne trovammo una
con la sigla della nostra provincia.
Ci appostammo, e appena il tipo comparve
Schizzo lo circuì. Lo convinse a portarla a casa, quindi saltai fuori anch’io. Il tipo salì in macchina «mi spiace, ma
non ho posto per due persone e i bagagli.» Schizzo bussò al vetro e alzando la
borsetta di cuoio disse con gli occhi gonfi «abbiamo solo questo». Impietosito ci caricò e ci portò fino a
casa, 700 chilometri con un unico passaggio: i buoni samaritani esistono.
La reazione di mia madre fu sintetica.
Esordì con «cosa feto ti casa?». Le spiegai del furto, così mi rimproverò
per avermi fatto rubare i vestiti, per tutti sembrava che la colpa fosse
nostra. Il giorno dopo chiamai Celeste all'albergo dov'era in ferie al mare. «Sono a casa, mi hanno rubato tutto.» «Se vuoi puoi venire da me, c’è posto.» «E con cosa vengo? non ho soldi.» «Sei andato a Barcellona in autostop, puoi
arrivare fino a Caorle» riagganciò.
Presi la bisaccia di cuoio che usavo come
cartella dalle medie, ci misi dentro un po’ di roba e partii, 120 chilometri, un’inezia,
un passatempo. Celeste si vendicò in modo scherzoso ma
efficace.
Arrivò un temporale estivo al mare, le
onde si ingrossavano e per me era un invito a tuffarmi e nuotare. Poi cominciò
la pioggia. Tutti raccolsero le cose, chiusero gli ombrelloni e si ripararono
dentro il bar della spiaggia. Tornato a riva non vidi la macchia di
colore dell’ombrellone, unico punto di riferimento per i miei occhi miopi.
Camminai sotto la pioggia, lungo la battigia, avanti ed indietro, solo, con
l’acqua sempre più scrosciante. Lo slip bianco, con impresse le testate dei più
famosi giornali e comperato in emergenza in un negozio fronte mare, si rivelò
incapace, una volta bagnato, di nascondere le intimità. Così mi ritrovai nudo,
in mezzo al nulla, sotto un temporale. Quando tutto finì Celeste venne a
raccogliermi. Mi avvolse con un asciugamano «bene, anche oggi
hai fatto la tua bella figura.» Il giorno dopo comperai un altro costume,
nero.
Era consuetudine, terminate le vacanze
estive, raccoglierci da Bano, nella sua taverna e raccontarci dei viaggi, delle
avventure e dell’ennesima espulsione da Taizé. Si parlava di Madrid, Grecia, Taizé e
altro. Schizzo ed io eravamo silenziosi, fino a
che Fayo disse «Oh, sapete cosa mi è successo a Taizé? Ho incontrato uno che
arrivava da Barcellona, mi ha detto che ha trovato due italiani davanti
all’Ambasciata. Tentavano di farsi dare dei soldi perché gli avevano rubato
tutto, che pollastri».
Tutti risero prendendo in giro quei due
poveri cristi.
Quasi tutti risero, a dire il vero.